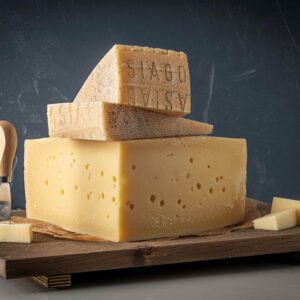Regioni continentali costantemente impegnate ad allontanare la troppa pioggia, mentre un’ampia fetta di Italia peninsulare fa i conti con precipitazioni scarse, temperature eccezionalmente miti, terreni aridi e riserve d’acqua pressoché esaurite: è questa la fotografia del Paese disegnata nel settimanale report dell’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche.
Il pericolo di nuovi allagamenti su territori come la Lunigiana è pressante, quando i terreni sono già imbibiti dagli accumuli di piogge pregresse ed i corpi idrici sono colmi: martedì, su molti comuni tra le Alpi Apuane e l’Appennino si sono registrate precipitazioni violente con cumulate fino a 160 millimetri in meno di 7 ore (la stazione di rilevamento di Campagrina – Stazzema ha rilevato oltre 400 millimetri di pioggia in 2 giorni, quella di Vergheto – Massa 320 millimetri – fonte: Sir); i livelli dei torrenti Carrione e Frigido sono cresciuti in pochissime ore rispettivamente di 2 metri e 2,5 metri facendo temere per la tenuta degli argini. Le “bombe d’acqua” hanno già provocato frane e disagi, mentre le previsioni per i prossimi giorni non promettono niente di buono né qui, né nelle regioni più a Nord, dove si prevedono altri nubifragi con accumuli superiori a 100 millimetri.
Al Centro-Sud, invece, le precipitazioni degli scorsi giorni non sono riuscite a rinvigorire corpi idrici, stremati da troppi mesi di siccità.
“Lo stato di riempimento dei bacini rimane critico– analizza Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi)- Da qui in avanti auspichiamo piogge frequenti e dolci per far sì che i terreni assorbano il giusto quantitativo di umidità, che le falde impoverite si ricarichino e che gli invasi si riempiano per scongiurare il rischio di vedere compromesse anche le future stagioni irrigue”.
Sono i dati della Sicilia a testimoniare più di tutti come le piogge, che stanno cadendo al Sud, non apportino benefici sufficienti a riequilibrare il disastroso bilancio idrico delle regioni meridionali: in una stagione piuttosto piovosa sull’isola (72 millimetri caduti in 20 giorni tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, cui vanno ad aggiungersi 32 millimetri di pioggia nella seconda decade di Ottobre – fonte Sias, elaborazioni Anbi) le riserve idriche hanno continuato a ridursi; tra il 22 settembre ed il 1° ottobre, nonostante la pioggia caduta, si è verificata un’ulteriore riduzione dell’acqua contenuta nei serbatoi, pari a circa 6 milioni di meri cubi.
Al Nord, invece, i grandi laghi mantengono altezze idrometriche superiori alla media, seppur registrando in qualche caso riduzioni settimanali; lo stato di riempimento del Maggiore è del 90,7%, Lario al 50,6%, Benaco al 62,1%, Sebino al 50,7%.
In Valle d’Aosta è in crescita la portata della Dora Baltea, mentre risulta decrescente quella del torrente Lys.
In attesa della prossima perturbazione prevista, il fiume Po registra una vistosa riduzione dei flussi in alveo, mantenendo però ancora portate abbondanti in Piemonte; nel tratto emiliano-lombardo persiste invece un marcato deficit idrico (-48% a Piacenza, -42% a Borgoforte).
In Piemonte calano i livelli del fiume Toce, mentre a crescere sono quelli della Stura di Demonte.
L’abbondanza d’acqua nei grandi laghi, unitamente ai livelli registrati negli altri bacini (+38%), consentono una riserva idrica alla Lombardia, indicata in 1596,3 milioni di metri cubi, pari a +12,3% rispetto alla media.
In attesa delle previste, forti piogge, il trend dei fiumi in Veneto, fatta eccezione per il Muson dei Sassi, risulta negativo.
In Emilia-Romagna, precipitazioni di notevole intensità hanno interessato alcune porzioni di Appennino (mm. 140 in 24 ore a Lago Scaffaiolo): a beneficiarne sono stati soprattutto i fiumi Secchia e Panaro, le cui portate sono cresciute notevolmente, superando quelle tipiche del periodo; deficitari, invece, gli altri bacini con quelli di Reno ed Enza, i cui flussi sono scesi addirittura sotto i minimi storici (fonte: Arpae).
In Toscana, i livelli dei fiumi nel Nord della regione sono tutti cresciuti vistosamente: tra gli incrementi più rilevanti, c’è quello del Serchio, il cui flusso è aumentato di 10 volte rispetto alla settimana scorsa, superando il valore medio dello scorso ventennio di ben il 265%! Invece, lì dove le piogge ancora latitano, le portate dei fiumi stentano a crescere come il caso dell’Ombrone, che questa settimana registra una nuova flessione, rimanendo ancora al di sotto del Deflusso Minimo Vitale.
Anche nelle Marche si continuano a registrare portate fluviali sotto media e livelli idrometrici tra i più bassi del recente quinquennio. In Umbria si abbassa di 1 ulteriore centimetro il livello idrometrico del lago Trasimeno e si riduce la portata del fiume Topino, che resta ampiamente deficitaria rispetto ai valori medi storici.
Nel Lazio, rispetto alla scorsa settimana, i laghi di Nemi, Albano e Bracciano registrano una decrescita di 2 centimetri nell’altezza idrometrica, così come quello di Vico, che segna -cm. 38 in soli 4 mesi; di 3 centimetri è invece il calo settimanale del lago di Bolsena. In riduzione sono anche le portate dei fiumi Tevere (-30% sulla media), Aniene e Velino che scende al valore di portata più basso da 8 mesi in qua (fonte: Aubac). Sulla regione sono previste ora precipitazioni intense come in Campania.
Scendendo più a Sud, continuano ad impoverirsi le riserve idriche, trattenute dalle dighe meridionali ed insulari, nonostante in alcune zone le piogge siano state violente.
In Basilicata, i volumi stoccati nei bacini sono ai minimi storici (mln. mc.93,46, cioè oltre 25 milioni in meno dell’anno scorso!) e le piogge cadute nei giorni scorsi non hanno minimamente incrementato i volumi invasati.
In Puglia, i serbatoi trattengono ora appena 50,52 milioni di metri cubi d’acqua; i volumi nel lago di Occhito sono scesi a mln. mc. 44,60, cioè sempre più vicino alla soglia dei 40 milioni, che costituiscono il “volume morto” del grande bacino posto al confine tra Molise e provincia di Foggia.
“Mettere in fila questi dati- conclude Massimo Gargano, direttore generale di Anbi- evidenzia in maniera palese quanto ribadiamo ancora una volta per aumentare la resilienza alla crisi climatica: la necessità di realizzare il Piano Invasi proposto da Anbi e Coldiretti e di completare gli schemi idrici. In sintesi, si tratta di infrastrutture sia per aumentare la capacità di trattenere l’acqua piovana che per trasferirla, laddove ce ne sia maggiore bisogno”.
 Stampa questa notizia
Stampa questa notizia