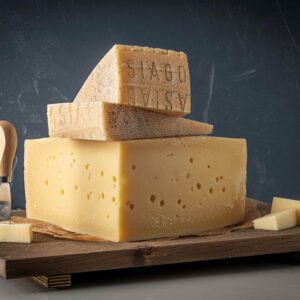RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Talvolta, ciò che distingue l’essere colto e consapevole da colui che si limita a navigare la superficie degli eventi è proprio la facoltà – socratica, dunque profondamente umana – di riconoscere i propri errori e di tornare sui propri passi. È un gesto che non ha nulla a che fare con l’umiliazione, come la cultura contemporanea spesso induce a credere. Anzi, è uno dei più alti atti di libertà interiore, quella libertà che, secondo Immanuel Kant, è possibile solo nella maturità del giudizio morale, quando l’individuo agisce non per tornaconto o per timore, ma perché “così deve essere”.
Dire “ho sbagliato” è, per molti, un cedimento. Ma nella visione dei grandi pensatori – da Platone a Simone Weil – è invece il primo passo verso la verità. Nella Repubblica, Platone ci ammonisce che vivere nella caverna dell’illusione è il destino di chi non ha il coraggio di voltarsi verso la luce. Ma colui che sceglie di farlo, colui che si gira e affronta la fatica di risalire verso l’Idea del Bene, quello è il vero filosofo: non infallibile, ma in cammino.
Anche Søren Kierkegaard, nella sua tormentata riflessione sull’esistenza, ci dice che la verità non si trova lungo la linea retta del successo o del consenso, ma spesso nello sprofondare nell’errore e nella vertigine del dubbio. L’importante è non restare fermi, inchiodati al proprio narcisismo intellettuale. L’uomo autentico, per Kierkegaard, è colui che sa “saltare” – compiere cioè il gesto esistenziale del ritorno, anche doloroso, alla sincerità con sé stesso.
Nietzsche, dal canto suo, pur ostile alle morali codificate, esaltava il potere trasformativo della crisi: solo chi sa “morire a sé stesso” può generare il nuovo. Ma per farlo, è necessario abbandonare l’orgoglio della coerenza cieca e accettare il disorientamento dell’errore come parte della costruzione del proprio pensiero.
E ancora: Hannah Arendt, nella sua riflessione sulla “banalità del male”, ci mostra come il vero pericolo per le democrazie moderne sia l’incapacità di riflettere criticamente sul proprio operato. L’errore, quando non viene nominato, si istituzionalizza. Il silenzio che segue la menzogna ne diventa complice. Per questo il coraggio di chiedere scusa, di rettificare, di tornare sui propri passi, è un atto politico oltre che morale. È la resistenza del pensiero contro la degenerazione del potere.
Persino nella liturgia della tradizione cristiana, così spesso fraintesa o ridicolizzata, la confessione dell’errore non è un gesto di sottomissione, ma un’opera di liberazione: “Confessare il peccato” – etimologicamente – significa “dire insieme” la verità, riconoscerla come bene comune, come strada da ricostruire assieme.
Viviamo invece in un’epoca che esalta la performance, l’efficienza, la continuità senza pause. In quest’ottica, tornare indietro sembra un fallimento. Ma l’anima educata sa che ogni cammino degno è fatto di esitazioni, di revisioni, di ripensamenti. Lo sbaglio non è inciampo: è materia viva del pensare.
Tornare indietro non è rinnegare, ma comprendere. E comprendere – “cum-prendere”, prendere insieme – è l’atto più profondo della conoscenza. Dunque sì: chi sa dire “ho sbagliato” non cade, si eleva. Non rinnega il proprio passo, lo redime. È questo il fondamento dell’etica nella storia, della giustizia nelle istituzioni, dell’autenticità nella cultura.
L’errore più grave, dopotutto, è restarvi aggrappati per paura di apparire deboli. La vera debolezza è non sapersi fermare. E solo chi si ferma, può – con passo più saldo – riprendere il cammino verso la verità.”
P.S.
Queste riflessioni non si riferiscono a persone o situazioni specifiche, ma vogliono offrire un pensiero universale sulla dignità dell’errore riconosciuto, nella storia della filosofia e della cultura.
 Stampa questa notizia
Stampa questa notizia