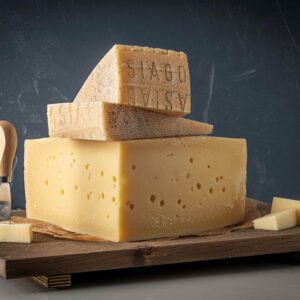a cura di Bruno Grotto
Una storia che non si limita alla genealogia. Ma che si trasforma in presenza, voce, testimonianza. Una storia che finalmente parla di umanità e di pace.
La madre di Leone XIV si chiamava Mildred Martínez. Non era nata nei salotti vaticani, ma tra i vicoli polverosi del Settimo Ward di New Orleans, un quartiere dove il tempo scorre a ritmo di tamburo e dove la pelle ha sempre avuto più di un significato. Terra creola, terra meticcia. Un luogo in cui la storia non si legge: si ascolta.
Secondo lo studioso Jari C. Honora, tutti e quattro i bisnonni materni del futuro papa erano registrati, già nell’Ottocento, come “persone di colore libere”. Una condizione ambigua, una libertà concessa ma non garantita. Una contraddizione vivente in un’America che ancora oggi fatica a guardarsi allo specchio. Erano uomini e donne che danzavano sul filo teso tra l’emancipazione e la segregazione. E che, forse proprio per questo, avevano imparato a resistere in silenzio.
Joseph Martínez, nonno del pontefice, veniva da Haiti — prima repubblica nera della storia, nazione nata dal fuoco e dal sangue. Torsolo di una memoria rivoluzionaria che si è fatta carne. Accanto a lui, Louise Baquiex, creola e cattolica, cresciuta tra l’incenso e le canzoni africane, tra le cucine dell’America latina e le regole del codice napoleonico. Una donna che sapeva cosa significa appartenere a due mondi senza essere del tutto accettata da nessuno.
Poi, la diaspora silenziosa. Chicago. Il freddo. L’invisibilità. Come molte famiglie creole, anche i Martínez scelsero il “passing”: abbracciare una bianchezza utile, strategica, mai del tutto vera. Ma sotto la superficie, la musica non tacque. L’identità divenne sussurro, poi vibrazione, infine ethos. Una memoria che non chiede documenti, ma che si trasmette come un canto dal colore e calore del cuore.
Leone XIV porta tutto questo con sé. È un pontefice che non viene solo dalla teologia, ma dalla geografia delle ferite, delle ingiustizie. Dal jazz, dal dolore e dalla speranza. I suoi vent’anni in Perù, sulle Ande, tra villaggi dimenticati e preghiere sussurrate in “Quechua”, simbolo di una visione del mondo (in quechua cosmovisión andina), basata su un equilibrio tra uomo, natura e spirito. Una visione che ancora oggi influenza pratiche spirituali e sociali nei territori delle Ande, hanno fatto di lui un interprete dell’umanità nascosta.
E poi c’è l’ironia. Quella ironia tagliente della storia: guardie svizzere in elmi da conquistadores a proteggere un papa cresciuto nel mondo dei conquistati. Ma forse è proprio questo il punto: il mondo, come il jazz, non ha paura della dissonanza. E Leone XIV è, forse, il primo pontefice a suonare in sincro con le nostre stonature.
 Stampa questa notizia
Stampa questa notizia